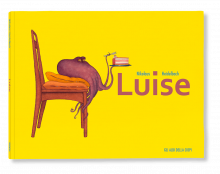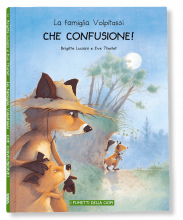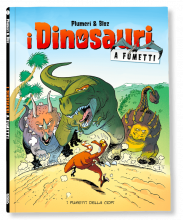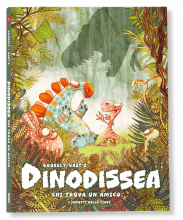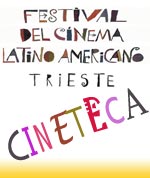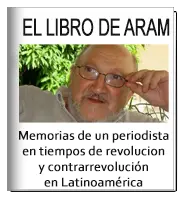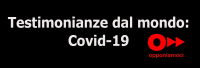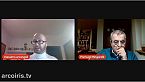Totale: 87739
Educar en el poder del todavía
¿Neurodidáctica, neuroeducación, neurociencia? ¿En qué se diferencian y cómo se pueden aplicar los avances científicos al aprendizaje? El profesor Chema Lázaro describe en este vídeo su propia experiencia en el aula y cómo se puede aprovechar la plasticidad del cerebro para estimular a los alumnos. “Hay oportunidad de aprendizaje en cualquier momento de la vida, cualquier alumno puede aprender. Tirando de las emociones debemos hacer que todos los alumnos ‘quieran’ aprender”, afirma el profesor. Su propuesta consiste en utilizar la mentalidad de ... continua
Visita: aprendemosjuntos.bbva.com
- Visualizzazioni: 1780
- Lingua:
 | Licenza: © all rights reserved
| Licenza: © all rights reserved
- Fonte: AprendemosJuntos | Durata: 55.47 min | Pubblicato il: 31-03-2021
-

- Categoria: AprendemosJuntos
- Condividi Commenta
iPhone 12 nasconde un segreto spaziale: Astro Talk
La presentazione dell'iphone di quest'anno può sembrare come le altre,a ma c'è qualcosa di diverso all'interno che ci farà parlare ancora una volta di spazio
Visita: shop.spreadshirt.it
- Visualizzazioni: 1006
- Lingua:
 | Licenza: © all rights reserved
| Licenza: © all rights reserved
- Fonte: Astro Filo | Durata: 22.43 min | Pubblicato il: 31-03-2021
-

- Categoria: Astro Filo
- Scarica: MP3 | MP4 | alta risoluzione
- Condividi Commenta
#DirectoStarTres Día del Asteroide
Adelantamos las celebraciones del Día del Asteroide junto a dos invitados de la Fundación Ciencias Planetarias y The Mars Society Chile.
- Visualizzazioni: 894
- Lingua:
 | Licenza: © all rights reserved
| Licenza: © all rights reserved
- Fonte: Star Tres | Durata: 91 min | Pubblicato il: 31-03-2021
-

- Categoria: Star Tres
- Scarica: MP3 | MP4 | alta risoluzione
- Condividi Commenta
Il padre dei vaccini - Edward Jenner
Il mondo, oggi, lotta contro la più terribile pandemia della storia contemporanea. La speranza, ancora una volta, è un vaccino.
Tra una protesta, una rivolta e una mascherina, la storia di Edward Jenner, l’uomo che ha scoperto la vaccinazione, è ancora più importante da raccontare.
- Visualizzazioni: 1997
- Lingua:
 | Licenza: © all rights reserved
| Licenza: © all rights reserved
- Fonte: Alessandro de Concini | Durata: 9.47 min | Pubblicato il: 31-03-2021
-

- Categoria: Alessandro de Concini
- Scarica: MP3 | MP4 | alta risoluzione
- Condividi Commenta
El emprendimiento sabe mejor cuando tu vida es un chorizo
EL EMPRENDIMIENTO SABE MEJOR CUANDO TU VIDA ES UN CHORIZO. Una entrevista donde veremos la historia de integración y lucha en un país muy diferente al de su origen Colombia. Este hombre llega a Francia para mostrarle al mundo que los preconceptos que se tienen de su país, no son más que eso, que los colombianos son gente pujante que aportan de forma positiva y productiva en la sociedad.
- Visualizzazioni: 691
- Lingua:
 | Licenza: © all rights reserved
| Licenza: © all rights reserved
- Fonte: Latinoticias - Journal Latino | Durata: 40.6 min | Pubblicato il: 30-03-2021
-

- Categoria: Latinoticias - Journal Latino
- Scarica: MP3 | MP4 | alta risoluzione
- Condividi Commenta
Lia Celi e Andrea Santangelo - Le due vite di Lucrezia Borgia
La lezione integrale di Lia Celi e Andrea Santangelo su "Le due vite di Lucrezia Borgia" al Festival del Medioevo 2019 (25-29 settembre, Gubbio).
- Visualizzazioni: 1574
- Lingua:
 | Licenza: © all rights reserved
| Licenza: © all rights reserved
- Fonte: Festival del Medioevo | Durata: 36.43 min | Pubblicato il: 30-03-2021
-

- Categoria: Festival del Medioevo
- Scarica: MP3 | MP4 | alta risoluzione
- Condividi Commenta
«La pata de mono», de W. W. Jacobs
«La pata de mono», de W. W. Jacobs, es el nonagésimo octavo relato del ciclo «Cuentos inolvidables»
Visita: www.hernancasciari.com
- Visualizzazioni: 731
- Lingua:
 | Licenza: © all rights reserved
| Licenza: © all rights reserved
- Fonte: Hernán Casciari | Durata: 4.23 min | Pubblicato il: 30-03-2021
-

- Categoria: Cuentos inolvidables
- Scarica: MP3 | MP4 | alta risoluzione
- Condividi Commenta
Dantedì - 700 anni dalla morte di Dante Alighieri - con Edoardo Boncinelli e Massimo Arcangeli
- Visualizzazioni: 1247
- Lingua:
 | Licenza: © all rights reserved
| Licenza: © all rights reserved
- Fonte: Festa Scienza Filosofia | Durata: 80.03 min | Pubblicato il: 30-03-2021
-

- Categoria: Festa di Scienza e Filosofia 2021
- Scarica: MP3 | MP4 | alta risoluzione
- Condividi Commenta
Filosofía en el Conti #Encuentro 6 con Alcira Bonilla
#Encuentro 6 / 21 de diciembre de 2017
Una Filosofía Intercultural: un desafío contemporáneo
Por Alcira B. Bonilla *
A comienzo de la década de 1990 numerosos filósofxs comenzaron a preguntarse por el destino de los estudios filosóficos, de raigambre europea y norteamericana, sobre todo, en el mundo globalizado. Como respuesta a esta inquietud, surgieron varias corrientes que plantearon la necesidad de ampliar los horizontes de la Filosofía, poniéndola en diálogo con producciones y modos de pensar diversos. En América Latina tales planteos se han ido ... continua
Una Filosofía Intercultural: un desafío contemporáneo
Por Alcira B. Bonilla *
A comienzo de la década de 1990 numerosos filósofxs comenzaron a preguntarse por el destino de los estudios filosóficos, de raigambre europea y norteamericana, sobre todo, en el mundo globalizado. Como respuesta a esta inquietud, surgieron varias corrientes que plantearon la necesidad de ampliar los horizontes de la Filosofía, poniéndola en diálogo con producciones y modos de pensar diversos. En América Latina tales planteos se han ido ... continua
Visita: conti.derhuman.jus.gov.ar
- Visualizzazioni: 753
- Lingua:
 | Licenza: © all rights reserved
| Licenza: © all rights reserved
- Fonte: El Conti | Durata: 44.77 min | Pubblicato il: 30-03-2021
-

- Categoria: El Conti
- Scarica: MP3 | MP4 | alta risoluzione
- Condividi Commenta
Intervista con Andrea Franzoso - Insegnare l'Educazione Civica
Nella nostra intervista con Andrea Franzoso, autore di Disobbediente, essere onesti è la vera rivoluzione e molti altri titoli, ci parla di come è diventato scrittore ma soprattutto di come si possa insegnare l'Educazione Civica in maniera efficace, facendo sviluppare ai ragazzi l'empatia.
Visita: www.direfareinsegnare.education
- Visualizzazioni: 696
- Lingua:
 | Licenza: © all rights reserved
| Licenza: © all rights reserved
- Fonte: Dire, fare, insegnare | Durata: 9.2 min | Pubblicato il: 30-03-2021
-

- Categoria: Dire, fare, insegnare
- Scarica: MP3 | MP4 | alta risoluzione
- Condividi Commenta